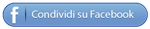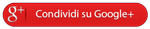Per anni sono stati relegati a scaffali specifici, etichettati per target, separati dal resto della narrativa. Poi qualcosa è accaduto: abbiamo capito che molte delle storie più profonde, universali e radicali del nostro tempo non stavano nei romanzi tradizionali, ma nelle tavole illustrate giapponesi.
La generazione dei manga
Il manga non è cambiato: siamo cambiati noi. La generazione che ne era lettrice silenziosa è cresciuta, ha occupato spazi culturali, ha iniziato a legittimarlo senza vergogna, e soprattutto ha smesso di considerarlo un prodotto allegro per adolescenti.
Chi legge Chainsaw Man non sta consumando un battle shonen splatter, ma una riflessione sulla fame emotiva. Chi legge Blue Period non segue un ragazzo che dipinge, ma un manifesto sull’identità e la pressione del talento. E chi ha pianto davanti a A Silent Voice sa che quello non è romanticismo scolastico: è il racconto più umano sul senso di colpa e sulla redenzione che si possa trovare oggi in libreria.
C’è poi un elemento unico del linguaggio manga che parla al nostro tempo: l’intensità emotiva non filtrata. L’Occidente spesso insegna a contenere, alludere, sublimare. Il manga fa il contrario: esplode, esagera, piange a gocce grandi, mostra crepe e fragilità senza giustificarsi. È catartico per un pubblico che vive in una società dove ci si aspetta forza, auto-controllo e riuscita, ma si ha bisogno di sentirsi fallibili, umani, complessi.
I manga al giorno d’oggi
Oggi il manga non compete con la narrativa occidentale: sta ridefinendo i canoni narrativi globali, influenzando cinema, moda, estetiche digitali, linguaggi memetici, e perfino i romanzi stessi che sempre più assumono ritmo, iconografia e tempista emotiva da storyboard nipponico.
Non è un trend: è un nuovo modo di costruire immaginazione collettiva. Quasi un vocabolario sentimentale condiviso.