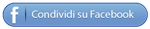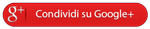Per decenni l’aurora boreale è stata sinonimo di viaggi nordici, notti gelide e latitudini estreme. Oggi non più. Gli ultimi anni hanno riscritto la geografia del fenomeno: anche l’Italia è entrata nella mappa delle avvistabilità, regalando cieli viola e colonne luminose dalla Valle d’Aosta alla Puglia. Non è turismo ottico, non è moda social: è fisica spaziale che cambia ritmo.
Il Sole si trova nella fase più intensa del Ciclo Solare 25, con un picco di attività previsto tra il 2024 e il 2026. Durante le eruzioni più potenti, il vento solare può comprimere la magnetosfera terrestre e spingere il fenomeno aurorale a latitudini insolitamente basse. Il risultato è un cielo che, anche nel centro Italia, può tingersi d’iridescenze rosse e verdi, per la gioia (e incredulità) di chi alza gli occhi.
Aurora boreale in Italia: tempeste solari, geomagnetismo e l’energia delle particelle
Alla fonte di tutto c’è la tempesta geomagnetica, un disturbo del campo magnetico terrestre causato dai brillamenti solari e dalle espulsioni di massa coronale. Quando queste nubi magnetizzate raggiungono la Terra, innescano la danza delle particelle nell’alta atmosfera, dove atomi di ossigeno e azoto reagiscono producendo luce.
Negli ultimi mesi hanno fatto notizia anche le cosiddette “tempeste solari cannibali”, evento in cui un’espulsione solare veloce ne raggiunge e ingloba una precedente, amplificandone l’energia. Un fenomeno raro, ma non eccezionale in periodi di massimo solare, in grado di potenziare l’effetto geomagnetico e aumentare la probabilità di aurore a latitudini medie.
In Italia, le regioni che hanno osservato più frequentemente bagliori aurorali sono Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, ma anche Marche, Abruzzo, Puglia e Sardegna hanno registrato scie rossastre visibili a occhio nudo. L’ingrediente chiave? Cielo scuro, bassa luminosità urbana e orizzonte libero.
Come riconoscere l’aurora (e non confonderla con luci artificiali)
L’aurora non è un flash, è un respiro. Cambia forma lentamente, pulsa, a volte sembra un sipario che si muove. In Italia, il colore più frequente è il rosso-rosato, perché compare a quote più alte e non richiede la piena intensità magnetica necessaria per il verde. Se sembra un “bagliore fisso” all’orizzonte probabilmente è inquinamento luminoso; se invece ha una struttura verticale, colonne o archi lievi, allora il cielo sta raccontando qualcos’altro.
Per osservarla serve poco: orientamento a nord, app meteo spaziale affidabile, notti limpide, zero fretta. Chi l’ha vista in Italia descrive la stessa sensazione: lo stupore della normalità che si incrina e lascia entrare l’eccezionale. Un istante cosmico che non chiede visti, solo occhi.